Ricevendo i presuli della Conferenza Episcopale Italiana Leone XIV ha detto: «andate avanti nell’unità, specialmente pensando al Cammino sinodale. Il Signore – scrive Sant’Agostino – «per mantenere ben compaginato e in pace il suo corpo, così apostrofa la Chiesa per bocca dell’Apostolo: Non può dire l’occhio alla mano: non ho bisogno di te; o similmente la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Se il corpo fosse tutto occhio, dove l’udito? Se il corpo fosse tutto udito, dove l’odorato?» (Esposizione sul Salmo 130, 6)»
E il Pontefice ha aggiunto: «Restate uniti e non difendetevi dalle provocazioni dello Spirito. La sinodalità diventi mentalità, penetri il cuore, i processi decisionali e i modi di agire».
Parole nette, che smontano ogni tentativo di rinchiudere il Sinodo in una griglia ideologica o in una bandiera di parte. Se qualcuno ha scelto di etichettare la sinodalità come strategia “progressista”, Leone XIV mostra invece come lo Spirito non sopporti né cricche né appartenenze di comodo: nella sinodalità tutti devono avere spazio ed essere ascoltati.
È proprio questa apertura universale – che affonda le radici nella spiritualità agostiniana – ad aver colpito positivamente molti vescovi e presbiteri in questi primi mesi di pontificato. Prevost, prima come Priore Generale e ora come Pontefice, ha dimostrato uno stile di ascolto reale, privo di pregiudizi. Ma chi lo conosce bene sa che, dopo l’ascolto, arrivano decisioni chiare: ferme, concrete, non rinviate. Non si tratta di un uomo spirituale avulso dalla realtà, ma di un pastore che sa distinguere tra dialogo e indecisione.
Eppure, la Chiesa degli ultimi anni è segnata da un’altra dinamica: le divisioni sono cresciute, la capacità di ascoltare chi la pensa diversamente si è ridotta. Anche tra vescovi e formatori si nota spesso una tentazione opposta a quella auspicata dal Papa: non tanto presiedere nella carità, quanto plasmare clero e fedeli secondo le proprie sensibilità personali, quasi fossero programmi da imporre. Così si finisce per confondere il piano della vocazione con quello del gusto individuale, lo Spirito Santo con le nostre preferenze, la grazia con le idee.
Nelle diocesi italiane, e non solo, si assiste sempre più spesso a un fenomeno che merita di essere osservato con attenzione: le riflessioni di fondo nei convegni del clero vengono affidate a sacerdoti che appartengono a correnti teologiche (meglio dire ideologiche) ben precise, spesso orientate verso una visione “progressista” o “modernista” della Chiesa. Non si tratta di una scelta neutra. Al contrario, questo metodo finisce per orientare l’intero dibattito, perché le parole pronunciate in quelle sedi non sono semplici opinioni personali, ma diventano cornice di riferimento per la vita di un determinato tipo di presbiterio.
Il problema è evidente: se il relatore è chiaramente schierato, non rappresenta la complessità del clero ma una sua parte. Ciò significa che, in un presbiterio già segnato da differenze di sensibilità e da fatiche pastorali, il momento che dovrebbe unire diventa occasione di divisione. Chi non condivide quella visione si sente automaticamente marginalizzato.
Perché accade questo? Per due motivi ricorrenti.
Una scelta di campo da parte dei vescovi, che preferiscono dare spazio a figure in grado di sostenere una determinata linea ecclesiale, anche a costo di escludere altre prospettive.
Un’idea implicita di riforma, secondo la quale il ministero presbiterale deve essere “ripensato” in senso nuovo, ridimensionando la mediazione sacramentale e spingendo verso un modello comunitario e sinodale che, però, rischia di appiattire le differenze e di impoverire la dimensione spirituale.
Il risultato è che, ancora una volta, a prevalere non è la voce della Chiesa intera — fondata sul magistero e sulla Tradizione viva — ma la voce di una corrente, che diventa proposta ufficiale, quasi magistero parallelo.
C’è un nodo preliminare, prima ancora di entrare nel merito teologico: perché affidare una meditazione al clero di una diocesi a un presbitero apertamente schierato su un’idea di Chiesa divisiva? In un presbiterio variegato, già provato da carichi pastorali e stanchezze, la scelta di un relatore “di scuola” non è neutra. È un atto di governo. E ogni atto di governo in ambito ecclesiale ha due effetti: forma la coscienza dei presenti e segna la direzione. La domanda, allora, è semplice: si vuole edificare l’unità o si accetta il rischio di accentuare linee di frattura?
Spesso le relazioni di questi personaggi che non indossano mai un colletto propongono un “ripensamento” del sacerdozio, che attraversa tre fasi storiche e sfocia in un’immagine di Chiesa sinodale nella quale “tutti i discepoli sono missionari”. L’assunto di fondo è chiaro: Tradizione come processo dinamico, non come deposito stabile, e dunque ministero continuamente ri-situato. È una tesi legittima da discutere, ma è anche un’impostazione rischiosa se non si dichiara con precisione che cosa resta non negoziabile. Il rischio? Che il “ripensamento” diventi sostituzione di fondamenti: dall’ontologia sacramentale a una funzionalità comunitaria.
Un problema di cornice: chi parla al presbiterio e a nome di chi?
La scelta del relatore non è un dettaglio organizzativo. Quando il vescovo affida una meditazione “matrice” per il convegno del clero, sta indicando un paradigma. Se il paradigma coincide con una specifica scuola teologica — per di più controversa — si produce esclusione percepita: chi non aderisce a quel lessico si sente marginale nella propria casa. È prudente? È paterno? È conforme alla responsabilità di Custode dell’unità? Qui non è in gioco la libertà accademica, ma la carità pastorale.
Inutili sono le affermazioni: “È una voce autorevole che appartiene al nostro presbiterio”. No. Quante volte chiamiamo persone da fuori per celebrare Sante Messe o tenere relazioni? Se in casa abbiamo un eretico, chiamiamo un eretico?
Non dimentichiamo che proprio lo scorso anno fu invitata una donna che, dopo aver girato l’Italia pontificando sugli abusi e dipingendo ogni sacerdote come un potenziale abusatore, è stata infine smascherata da Silere non possum: si presentava come psicologa e psicoterapeuta, ma in realtà non possedeva alcun titolo. Al Convegno del Clero, con la stessa arroganza, aveva pontificato spiegando ai preti come dovrebbero essere preti, senza però offrire nella concretezza alcuno spunto pratico (e come potrebbe farlo una donna?)
Il criterio minimo, in un tempo polarizzato, dovrebbe essere questo: una parola capace di includere, non di etichettare. La creatività pastorale — se è tale — non si nutre di provocazioni sloganistiche, ma di chiarezza dottrinale e concretezza operativa. E proprio questi due elementi, spesso, restano i punti più deboli.
Il tono di certi interventi rivolti al clero appare spesso paternalistico, quasi con l’atteggiamento di chi dice: “Adesso vi spiego io come dovete essere preti”. E a pronunciarli, curiosamente, sono quasi sempre professori o teorici che non hanno mai portato sulle spalle la responsabilità quotidiana di una parrocchia.
Lo schema di fondo che viene proposto è sempre il medesimo: una ricostruzione storica del ministero che passa dall’antica collegialità alla forma individuale, dal Vaticano II con il richiamo ai tria munera e alla priorità dell’annuncio, fino a una visione ecclesiologica dei ministeri collocati “dentro” il popolo di Dio, con un’enfasi marcata sul sensus fidei. Un percorso che in sé potrebbe avere anche una sua logica, ma che porta con sé tre slittamenti critici.
1. Tradizione come “ovvietà” da decostruire. Si sostiene che l’idea di una fissità dogmatica sarebbe solo un’illusione da correggere. Ora, nessuno mette in discussione che la Tradizione viva si sviluppi nel tempo; ma sviluppo non significa trasformazione dell’identità. Se la forma del ministero deve mutare ad ogni contesto storico, chi garantisce la continuità ontologica del presbiterato? Qual è il punto in cui si dice: “oltre questo non si può andare”?
2. Cristologia in secondo piano. La proposta di passare da una fondazione cristologica a una fondazione ecclesiologica è presentata come progresso. Ma un’ecclesiologia senza cristologia è monca: il presbitero non è un semplice incaricato della comunità, bensì un uomo configurato a Cristo Capo. L’accento comunitario ha il suo valore, ma non può oscurare la radice sacramentale, che non nasce “dal basso”.
3. Da mediatore ad animatore. In alcuni discorsi si tende a negare la mediazione del prete, riducendolo a facilitatore di processi comunitari. Ma la dottrina cattolica afferma con chiarezza: il presbitero agisce in persona Christi capitis come segno efficace di mediazione. Non in alternativa a Cristo, ma come strumento di Cristo stesso. Negare questo significa svuotare il sacramento dell’Ordine e ridurlo a una funzione sociale.
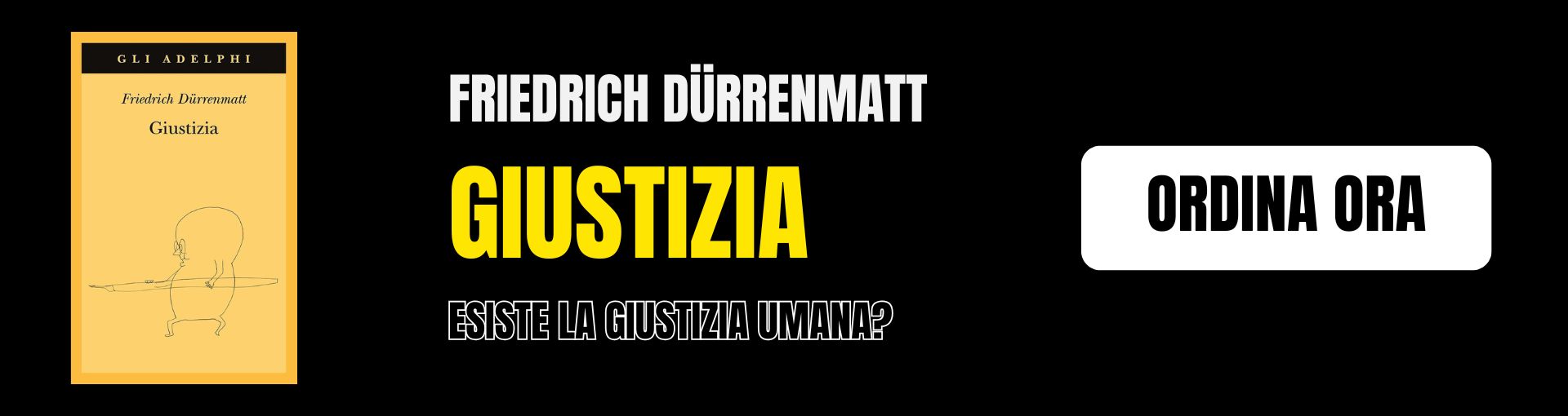
Categorie sociologiche, discernimento spirituale e il corto circuito del “trial and error”
Un altro elemento ricorrente è la proposta di applicare alla vita pastorale il metodo “scientifico” del trial and error: provare, fallire, correggere, riprovare. In apparenza sembra un approccio ragionevole. Ma la pastorale non è un laboratorio neutro. Il discernimento nella Chiesa non è mai puramente tecnico: è un atto teologale, radicato nella fede e nella grazia. Certo, servono verifiche e dati concreti; ma senza criteri di verità — Cristo, i sacramenti, i tria munera, la cura delle anime — ogni sperimentazione rischia di ridursi a puro pragmatismo.
Allo stesso modo, non meno problematico è l’uso insistente di categorie politiche come “populismi” o “crisi della partecipazione” per interpretare la vita ecclesiale. Sono fenomeni reali, ma non possono diventare la lente principale per leggere il mistero della Chiesa. Se la griglia di riferimento è quella della democrazia occidentale, il risultato sarà l’immagine di un presbitero manageriale, un mediatore di interessi, un facilitatore di processi. Ma la verità del ministero è un’altra: il presbitero, in forza del sacramento dell’Ordine, santifica, insegna e governa, non perché rappresenta la base, ma perché rende presente Cristo Capo.
L’intenzione buona e l’esito cattivo: dalla corresponsabilità al clericalismo rovesciato
Che la corresponsabilità dei fedeli debba essere valorizzata è indubbio. Tuttavia, questo continuo richiamo ai ministeri istituiti rappresenta un segnale che più volte abbiamo osservato. Quante volte, infatti, capita di incontrare laici che aspirano al titolo di “catechista istituito”, “lettore istituito” e simili, non per autentico spirito di servizio ecclesiale, ma per il desiderio di rivestire un ruolo, indossare un abito, colmare fragilità personali. Inoltre, la spinta in questa direzione spesso scivola in una pratica che svuota il ruolo del presbitero, riducendolo a un semplice coordinatore di apparati. Si insiste su leadership, organizzazione, governance: aspetti certamente utili, ma che finiscono per spostare l’accento sul come amministrare più che sul che cosa custodire e perché.
Il paradosso è evidente: si denuncia giustamente il rischio del “funzionarismo” sacerdotale — preti oberati da celebrazioni a catena, burocrazia edilizia, pratiche amministrative — ma nello stesso tempo si propongono ulteriori strumenti di gestione, nuove strutture, nuovi processi. È questa la strada? Quando invece l’urgenza vera è un’altra: più preghiera, più formazione umana ed affettiva, più adorazione eucaristica, più ore neiconfessionali, più ore a fare direzione spirituale, ecc… È questo che i sacerdoti giovani oggi chiedono; ed è questo che il popolo fedele — quello reale, non quello costruito attorno a tavolini tondi — continua a domandare con insistenza.
Omologare o riconoscere i carismi? L’inerzia degli schemi ideologici
Molti discorsi ecclesiali cercano oggi di leggere il presente, ma finiscono spesso per cadere in schemi ideologici: da una parte il richiamo a non condannare la cultura (cosa buona), dall’altra la constatazione che essa non offre più un ethos condiviso (dato reale). Il risultato è quasi sempre la spinta verso “nuove forme” e “nuovi processi”, senza però fare i conti con un punto decisivo: la singolarità dei carismi. Dove si trova l’ascolto reale dei presbiteri, con la loro storia concreta, i loro doni e le loro ferite?
Quando si parla di “selezionare le attività”, “ridurre le Messe” o “riconvertire gli oratori”, ci si muove certo in un ambito che può richiedere decisioni pratiche. Ma quali? E con quali criteri teologici e spirituali? Limitarsi alla categoria dell’“efficacia missionaria” — chiedendosi cioè se una certa iniziativa avvicina o meno a Cristo — resta un criterio nobile ma insufficiente, se non si chiarisce che cosa significa davvero avvicinare a Cristo: fede viva, partecipazione ai sacramenti, vita di grazia. Senza queste coordinate, la formula resta vaga e rischia di diventare puramente retorica.
Alcune considerazioni
Un primo nodo riguarda il rapporto tra il sensus fidei e il magistero. È giusto valorizzare l’intuito della fede che lo Spirito dona a tutto il popolo di Dio, ma se lo si presenta come una sorta di plebiscito si cade in un equivoco. Lumen Gentium è molto chiara e il punto 12 va letto con il 25: il sensus fidelium non è la somma delle opinioni, ma il consenso nello Spirito a una verità che la Chiesa insegna. Senza questo riferimento al magistero, il richiamo rischia di rimanere sbilanciato.
Un secondo punto è la questione dei tria munera. È vero che l’annuncio ha una sua priorità logica, ma non è l’unico compito. Se l’annuncio non conduce all’atto sacramentale — Eucaristia, riconciliazione, unzione — si scivola in una pastorale fatta solo di parole, senza incarnazione concreta della grazia.
Terzo: i ministeri istituiti. Che vadano promossi e riconosciuti è fuori discussione, ma non si può confondere la loro natura con quella dei ministeri ordinati. I primi hanno una funzione preziosa ma di carattere pratico; i secondi hanno un carattere sacramentale e ontologico. Metterli sullo stesso piano produce confusione ed è un tentativo di clericalizzare il laico.
Altro aspetto delicato è la sinodalità. Che la Chiesa debba camminare insieme è chiaro. Ma sinodalità non significa trasformare la vita ecclesiale in un parlamento o in una negoziazione infinita. Il cammino comune ha senso se porta a decisioni concrete radicate nella verità della fede; altrimenti si riduce a metodo senza contenuto.
Infine, la questione della leadership. Certo, è assolutamente necessario acquisire competenze organizzative e gestionali, ma la leadership nella Chiesa non è quella di un’impresa: è paternità spirituale. Ogni volta che si sono importati modelli mondani negli spazi ecclesiali, il risultato è stato disastroso. E il rischio, oggi come allora, è di creare una nuova forma di clericalismo: diversa nello stile, ma altrettanto pericolosa nella sostanza.

Unità, non uniformità: il compito dei vescovi
Se il punto è custodire l’unità, allora la prima riforma è la scelta dei relatori. Non figure di parte, ma voci capaci di tenere insieme: Tradizione viva e missione, sacramento e profezia, autorità e ascolto. Figure moderate — non ideologiche — che uniscano rigore dottrinale e intelligenza pastorale. Perché l’unità non nasce cedendo sui contenuti, ma tenendo ferma la verità con carità.
E, nel merito, un chiarimento non eludibile: il presbitero è un uomo consacrato, configurato a Cristo Capo, ordinato per la Parola e i Sacramenti e posto a guida del popolo. Ogni “ripensamento” che non parta da qui non è cattolico; è altro. Non tutto ciò che è pratico è pastorale; non tutto ciò che è nuovo è evangelico; non tutto ciò che è condiviso è vero.
Ripensare sì, sostituire no
Ripensare il ministero presbiterale in una Chiesa di discepoli missionari è necessario. Ma “ripensare” non significa cambiare natura. Significa custodire la forma di Cristo più intensamente, in un tempo che chiede chiarezza e santità più che convegni. È questo che un vescovo dovrebbe offrire al suo clero: parola che unisce, dottrina che sostiene, indicazioni che liberano. Tutto il resto — lo abbiamo imparato — divide, stanca e, alla lunga, svuota.
d.L.M. e d.G.M.
Silere non possum