La Chiesa porta in sé una tensione che non possiamo eludere: luci e ombre convivono nello stesso corpo. Da un lato, la forza di un annuncio che da duemila anni attraversa i secoli e che i credenti riconoscono come via necessaria alla salvezza; dall’altro, il peso di comportamenti e dinamiche che ricordano più da vicino le logiche di una setta che quelle di una comunità di fede. È in questo spazio di contraddizione che oggi molti cattolici si trovano a vivere, sospesi tra la bellezza liberante del Vangelo e il soffocamento di un giudizio che sembra non conoscere tregua.
Non è facile dirlo ad alta voce, perché tocca un nervo scoperto. Eppure, basta osservare con un minimo di onestà quanto accade ogni giorno, dentro parrocchie, movimenti e gruppi ecclesiali, per accorgersi che una parte significativa della vita comunitaria ruota attorno al giudizio sugli altri, non all’annuncio del Vangelo.
È accaduto anche nelle ultime ore. Un sacerdote, al solo fine di finanziare e favorire le attività nelle quali è impegnato, ha usato i social per sponsorizzare un prodotto. Nel giro di poche ore, attorno a quel gesto si è scatenato un processo collettivo: screenshot condivisi, commenti indignati, accuse di incoerenza, fino a trasformare un fatto minimo in un caso da tribunale. Non un tribunale ecclesiastico, ma un tribunale parallelo, alimentato dal passaparola, dai social, dal bisogno di sorvegliare e punire.
Qualunque gesto compia un sacerdote sui social, c’è sempre qualcuno pronto ad avere da ridire: confratelli o laici, poco cambia. Fai una battuta durante l’omelia e subito scattano le accuse; indossi la veste e ti rimproverano di fare “la passerella”; non la indossi e ti accusano di non vestire come dovresti. Insomma, qualunque scelta diventa bersaglio di critiche.
È chiaro: se un sacerdote balla davanti all’altare o profana l’Eucaristia, la questione è grave ed è giusto indignarsi. Ma ben diverso è quando a un prete viene negata persino la possibilità di vivere la propria vita in modo sereno, senza il timore costante di essere osservato, giudicato e commentato. Qui, evidentemente, qualcosa non funziona.
Questa è la parte più evidente. Ma la radice è più profonda. Lo stesso meccanismo scatta di fronte a una foto di un prete in palestra, a una storia pubblicata con un/una amico/a, a una frase interpretata come ambigua. Ci sono perfino soggetti repressi che, con un’ossessione degna di un investigatore privato, arrivano a fare ricerche su Google per individuare il luogo esatto in cui una persona si trovava al momento della pubblicazione di una foto e creano profili fake per stalkerizzare. È un modo di vivere la propria vita che è tipico di chi non è realizzato e ci offre una immagine di una fede che non ha nulla di evangelico. È controllo sociale, voyeurismo spirituale, sorveglianza reciproca.
Il meccanismo del giudizio: psicologia e bisogno di sicurezza
Gli psicologi hanno spiegato a più riprese perché questo accade. Erik Erikson ci ricorda che l’essere umano, per sentirsi sicuro, ha bisogno di identità. In contesti comunitari, questo bisogno si traduce spesso in rigidità: per difendere il proprio ruolo all’interno del gruppo, si osserva e si giudica chi non rientra nei canoni. Il giudizio, dunque, non serve a difendere Dio, ma a difendere il proprio fragile senso di appartenenza.
La teoria della dissonanza cognitiva di Leon Festinger offre un’altra chiave di lettura. Se io non riesco a vivere fino in fondo le norme religiose, se inciampo e fallisco (come capita a tutti, del resto), giudicare gli altri diventa un meccanismo per alleviare il mio senso di colpa: “Io non sono perfetto, ma almeno non sono come lui”. Così, il giudizio diventa un anestetico per la coscienza.
René Girard, con la sua teoria del capro espiatorio, aggiunge un tassello decisivo: le comunità, per mantenere la propria unità interna, hanno bisogno di individuare un colpevole. Colui che “sbaglia” diventa il bersaglio su cui proiettare le tensioni del gruppo. Ecco perché un prete che posta una foto in palestra o una suora che scrive un pensiero “fuori dagli schemi” diventano rapidamente oggetto di sospetto e di derisione: non per la gravità del fatto, ma perché servono al gruppo per cementare la propria identità.
Una fede che scivola nell’ideologia
Teologi e santi non hanno mancato di avvertire di questo pericolo. Joseph Ratzinger, già negli anni Sessanta, in Introduzione al cristianesimo, avvertiva che la fede può facilmente trasformarsi in ideologia: un sistema di appartenenza, più che un incontro con il Dio vivente. Quando questo accade, l’attenzione non è più rivolta alla verità del Vangelo, ma alla difesa di un’identità chiusa e ossessiva.
Henri Nouwen, con la sua fine sensibilità spirituale, osservava che il giudizio è spesso un modo per evitare il confronto con la propria vulnerabilità. È più facile puntare il dito sugli altri che lasciarsi guardare da Dio nella propria fragilità. Giudicare diventa, allora, una difesa. Ma una difesa che tradisce il Vangelo.
Non sorprende che Papa Francesco, nell’Evangelii Gaudium (n. 94), abbia parlato di “mondanità spirituale”: una forma di religiosità che, anziché aprire al Vangelo, si concentra sull’immagine, sul controllo, sull’esibizione di ortodossia. Una mondanità che “in alcuni casi assume l’apparenza di un fervore religioso”, ma che in realtà nasconde il bisogno di potere e di autoaffermazione. Ed è proprio per questo che certi ambienti, dove di giorno si ostenta la devozione tra pizzi e merletti liturgici e di notte si frequentano pizzi e merletti di ben altra natura, finiscono per essere quelli che dedicano più energie a giudicare e diffamare gli altri.
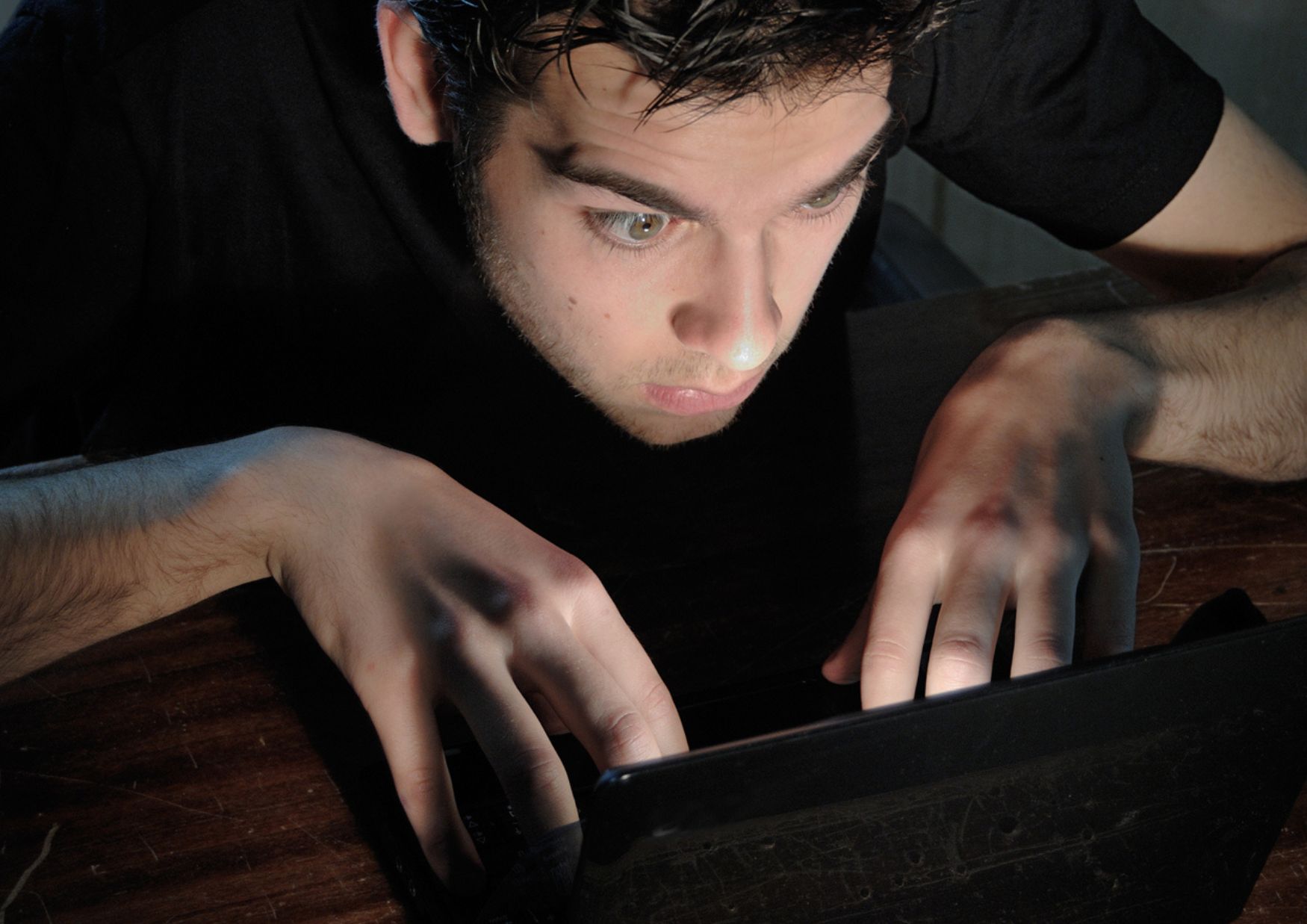
La sociologia del controllo religioso
Gli studiosi della religione hanno notato che queste dinamiche si accentuano nei momenti di crisi. Peter Berger ha mostrato come, nelle società secolarizzate, le comunità religiose reagiscano chiudendosi: più cresce la paura di perdere rilevanza, più si irrigidisce il controllo interno. In altre parole: più la Chiesa perde presa nella società, più al suo interno si moltiplicano i “guardiani della purezza”.
Zygmunt Bauman, a sua volta, ci ricorda che il giudizio è un surrogato di sicurezza: giudicare l’altro mi fa sentire stabile, mi protegge dall’incertezza del mio cammino. Ma questa stabilità è un’illusione: si regge sulla condanna altrui, non sulla libertà evangelica.
Dinamiche da setta
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Una parte della vita ecclesiale assomiglia sempre più a una setta:
c’è un dentro e un fuori, con linee di demarcazione sempre più rigide;
c’è un controllo reciproco, che si alimenta di mormorazioni, screenshot, profili fake, condivisioni, calunnie e diffamazioni, passaparola, sentito dire;
c’è un meccanismo di sorveglianza che trasforma la comunità in un luogo di paura, non di libertà.
Chi è dentro trova in questo un senso di appartenenza: “noi siamo i veri custodi della fede”. Ma chi guarda da fuori percepisce solo un clima soffocante, lontano anni luce dall’annuncio di Gesù. Non a caso, tanti credenti autentici si allontanano proprio da queste comunità, più interessate a difendere sé stesse che a testimoniare la libertà del Vangelo. E se ci facciamo caso, queste dinamiche si inaspriscono soprattutto nei movimenti religiosi e nelle comunità, vere e proprie “sotto-categorie” del mondo ecclesiale, dove la logica del preservarsi e del difendersi dall’esterno diventa quasi una regola di sopravvivenza. Focolarini, Neocatecumenali, Comunione e Liberazione, Nuovi Orizzonti, Opus Dei: l’elenco potrebbe continuare. Ma il meccanismo è lo stesso. Più ci si chiude in comunità piccole, più queste dinamiche di controllo e giudizio si accentuano, fino a diventare soffocanti.
Il paradosso cristiano
C’è un paradosso che grida. Il Vangelo ci consegna un Dio che non giudica, che accoglie, che libera. “Non giudicate, per non essere giudicati” (Mt 7,1) è una delle frasi più nette di Gesù. Eppure, proprio nella comunità che porta il suo nome, si moltiplicano i piccoli e grandi tribunali paralleli.
Così, il cristianesimo, che dovrebbe essere spazio di misericordia, diventa sistema di controllo; il luogo della libertà dello Spirito si trasforma in gabbia di sorveglianza. In questo scarto si gioca molta della crisi attuale della Chiesa: non è il Vangelo che allontana, è il suo tradimento quotidiano, mascherato da zelo e da ortodossia.
Una domanda aperta
Forse la vera domanda che dovremmo porci è questa: che immagine di Dio trasmettiamo quando viviamo nella logica del giudizio e della sorveglianza?
Un Dio che spia le storie di Instagram dei suoi figli, che fa screenshot dei loro errori, che diffonde i loro fallimenti come avvertimento agli altri? Un Dio che giudica ogni azione, anche quelle più leggere? O il Dio del Vangelo, che “non è venuto a condannare il mondo, ma a salvarlo”?
La risposta è evidente. Ma il cammino per tornare a viverla è ancora tutto da compiere.
d.G.V.
Silere non possum