Ogni giorno conversiamo con una macchina, spesso senza rendercene conto. Ci suggerisce le parole, corregge gli errori, ci ricorda gli impegni. Ma, silenziosamente, ci osserva anche pensare.
Ethan Mollick la guarda senza paura e la chiama “compagna di viaggio”. “Co-intelligenza”, la definisce: un incontro tra due menti che non si escludono, ma si intrecciano. E in questa fusione — fragile, rischiosa, ma affascinante — si gioca forse il futuro dell’umano: non chi pensa meglio, ma chi sa pensare insieme. Viviamo un tempo in cui l’intelligenza non cresce, si replica. Le macchine imitano il pensiero, lo moltiplicano in superficie, mentre l’uomo rischia di perderne la profondità. La chiamano Artificial Intelligence, ma Ethan Mollick parla piuttosto di “co-intelligenza”: non un aumento di sapere, ma la necessità di un nuovo dialogo tra mente e algoritmo.
In un mondo dove gli algoritmi ci accompagnano in ogni gesto — dal lavoro al pensiero, dalla scrittura alla preghiera digitale — Mollick invita a guardare all’AI non come a un sostituto, bensì come a un alleato cognitivo. “La co-intelligenza è ciò che accade quando umani e macchine imparano a pensare insieme. Non è una somma, ma una fusione: una nuova forma di mente condivisa.” (E. Mollick, Co-Intelligence, 2024)
È una tesi che spiazza. Perché sposta l’attenzione dal tema, sterile, della competizione — “chi è più intelligente?” — a quello, molto più fecondo, della cooperazione. L’AI, secondo Mollick, non è il nemico da combattere, ma un linguaggio da imparare. Il futuro non sarà dominato dalle macchine, ma da chi saprà dialogare con esse in modo intelligente e umano. “Chi rifiuta l’uso dell’AI si esclude dal mondo del pensiero e del lavoro. Chi la usa male, rischia di perderne il senso. Solo chi impara a collaborare con essa potrà restare davvero umano.” (E. Mollick, Co-Intelligence, 2024)
Etica della collaborazione
Tuttavia, collaborare con l’AI non è un gesto neutro. È un atto morale. Ogni volta che deleghiamo una decisione, un testo, un’immagine a una macchina, esercitiamo un potere che chiede di essere accompagnato da responsabilità. Mollick lo riconosce: “Usare l’AI bene significa educarla, non soltanto addestrarla. È un lavoro etico, non tecnico.” E qui la riflessione si apre naturalmente al pensiero della Chiesa.
Nel suo intervento al G7 del 14 giugno 2024, Papa Francesco ha ribadito con chiarezza la visione della Chiesa secondo cui la tecnologia deve restare al servizio dell’uomo, mai il contrario. Il Pontefice ha innanzitutto ricordato che «l’intelligenza artificiale è innanzitutto uno strumento» e che «i benefici o i danni che essa porterà dipenderanno dal suo impiego». È un’affermazione che pone al centro la libertà e la responsabilità umana: la tecnica non è autonoma, ma dipende dal fine per cui viene utilizzata. Per questo il Papa ha ammonito che «solo se sarà garantita la loro vocazione al servizio dell’umano, gli strumenti tecnologici riveleranno la dignità unica dell’essere umano». La tecnologia, dunque, non può diventare un fine a sé stessa, ma deve essere ordinata al bene integrale della persona.
Francesco ha poi precisato che «all’essere umano deve sempre rimanere la decisione» e che occorre «garantire e tutelare uno spazio di controllo significativo dell’essere umano sul processo di scelta dei programmi di intelligenza artificiale: ne va della stessa dignità umana». Nessuna macchina, ha aggiunto, «dovrebbe mai scegliere se togliere la vita ad un essere umano».
In questo senso, la Chiesa riafferma la centralità antropologica dell’uomo: l’essere umano, creato a immagine di Dio, non può essere sostituito da alcuna forma di intelligenza artificiale. Ogni progresso tecnico deve restare ancorato a un discernimento etico, perché — come ha detto Francesco — «affinché questi ultimi [i sistemi di IA] siano strumenti per la costruzione del bene, debbono essere sempre ordinati al bene di ogni essere umano. Devono avere un’ispirazione etica».
Il Papa ha anche messo in guardia dal cosiddetto «paradigma tecnocratico», che rischia di trasformare lo strumento tecnologico in una nuova ideologia del dominio: «Non possiamo permettere a uno strumento così potente di rinforzare un tale paradigma, ma anzi dobbiamo fare dell’intelligenza artificiale un baluardo proprio contro la sua espansione». L’intelligenza artificiale, infatti, mette alla prova la visione antropologica cristiana: chi è l’uomo, se una macchina può scrivere, comporre, pensare? Mollick sostiene che l’intelligenza non è solo calcolo, è relazione. È la capacità di mettersi in ascolto, di interpretare, di creare senso. “L’AI non sa cosa sia la verità, ma può aiutarci a cercarla, se la usiamo come uno specchio della nostra mente e non come un suo sostituto” (E. Mollick, Co-Intelligence, 2024).
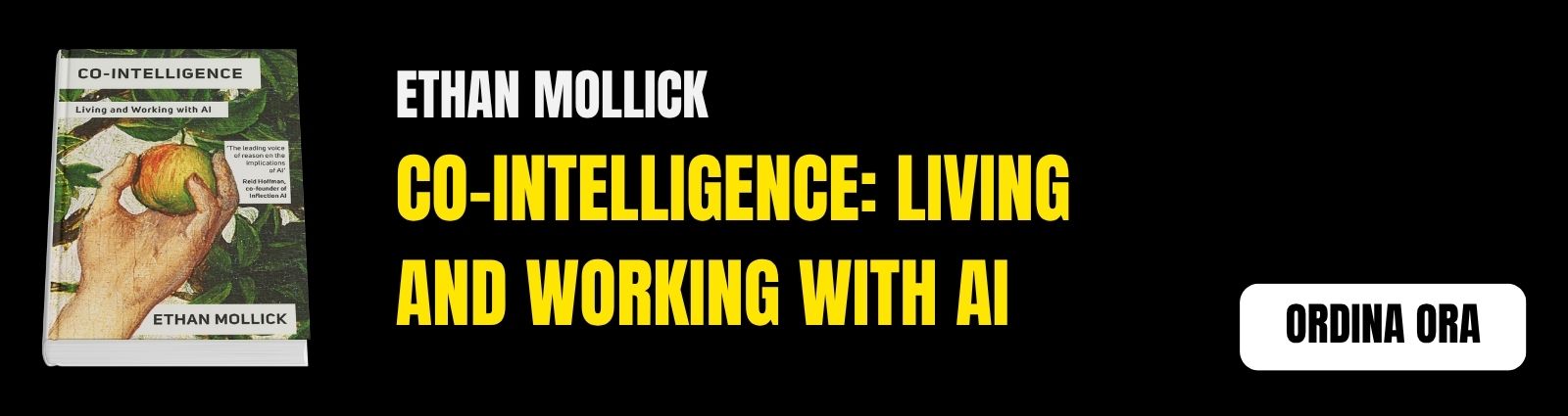
L’uomo come curatore dell’intelligenza
Nell’universo dell’AI, l’uomo non è più autore unico, ma curatore di senso. Questo ruolo richiama da vicino il compito che, nella Genesi, Dio affida all’uomo nel giardino dell’Eden: “coltivare e custodire” (Gen 2,15). Custodire oggi significa anche orientare la macchina verso il bene, ricordandole — anzi, ricordandoci — che la conoscenza non è mai neutra. Il rischio non è che l’AI diventi troppo intelligente, ma che l’uomo smetta di esserlo moralmente.
Che deleghi la responsabilità alle macchine, come già delega la coscienza alle mode, la memoria ai social, la verità agli algoritmi. Eppure, come ricorda Mollick, “la responsabilità resta nostra: ogni output dell’AI è anche un atto umano, perché siamo noi a scegliere come usarlo.”
Un’alleanza fragile ma necessaria
Forse la vera sfida non è impedire che l’AI diventi simile all’uomo, ma fare in modo che l’uomo non diventi simile all’AI. Non possiamo più tornare indietro: viviamo già in un mondo di co-intelligenze. Ma possiamo scegliere come abitarlo. Possiamo farlo come dominatori, illusi di controllare tutto, o come custodi, consapevoli che ogni tecnologia rivela ciò che siamo.
La Chiesa, con la sua lunga memoria dell’umano, può offrire qui una chiave decisiva: non basta programmare eticamente, bisogna educare alla sapienza. È questo che Leone XIV farà certamente con l’Enciclica che sta preparando. L’AI potrà diventare strumento di giustizia, di conoscenza e di dialogo solo se sarà inserita in una cultura che non abbia smarrito la distinzione tra verità e efficienza, tra bene e funzionalità.
Co-Intelligence non è solo un libro sulla tecnologia. È una riflessione antropologica: cosa significa essere umani in un mondo dove l’intelligenza si è moltiplicata? Mollick non offre risposte dogmatiche, ma apre spazi di discernimento. E questo, in fondo, è il compito più evangelico che ci sia: discernere gli spiriti, anche quando prendono la forma di codice e silicio.
“L’AI non ci sostituirà, ma ci rivelerà. Mostrerà chi siamo, a seconda di come scegliamo di usarla.” (E. Mollick, Co-Intelligence, 2024).
s.T.A.
Silere non possum