Quando, ieri mattina, Leone XIV è apparso all’ingresso dell’Aula della Benedizione, tutti hanno notato il suo consueto volto gioviale e sereno, e quella risata fragorosa scambiata con i collaboratori: un dettaglio che, prima ancora delle parole, ha disteso il clima fra i curiali. Prevost appare, con coerenza, come un uomo di letizia: sorridente, luminoso, interiormente libero da quella postura tetra, guardinga, quasi permanentemente in allerta che, in altri tempi, è stata scambiata per cifra dell’autorevolezza. Il suo tratto non è l’ingenuità; è una forma di sicurezza non aggressiva, capace di mettere l’altro a proprio agio senza abbassare di un millimetro la misura del ruolo.
Sì, Leone XIV sale sul trono predisposto dal cerimoniale. Ma lo abita in modo inusuale: con la postura di chi si fa prossimo, non di chi si colloca in alto per presiedere da lontano. È la differenza, sottile e decisiva, tra un potere che si esibisce e un’autorità che si lascia avvicinare. Fin dai primi giorni del pontificato, Leone ha mostrato di saper stare ovunque: a pranzo con i poveri della Caritas, nel protocollo con i diplomatici, nel dialogo con i sacerdoti, nella prossimità con i laici, con le religiose, con i non cattolici. Non cambia linguaggio per sedurre un pubblico: cambia registro per rispettare l’interlocutore.
C’è, in questo stile, una cifra ulteriore: Leone indossa ciò che gli viene dato con umiltà e con una calma che sa di fiducia. Per lui affidarsi non è un’umiliazione; è un atto di realismo, la consapevolezza che la Chiesa vive di legami, non di sospetti. E proprio questo manda in crisi una parte del racconto mediatico: perché disinnesca la narrativa del conflitto permanente, mentre genera pace e serenità non solo entro le mura leonine. Per tredici anni, invece, si è sedimentata l’idea che l’autorità dovesse mostrarsi con volto arcigno, con un timbro rabbioso, con una cadenza quasi strutturalmente inquisitoria; che ogni richiamo alla forma del papato fosse un residuo da rigettare; che la severità fosse garanzia di autenticità. I risultati, a lungo andare, sono stati sotto gli occhi di tutti: stanchezza, chiusura, risentimento, un senso di perenne giudizio che raramente produce conversione e molto spesso produce irrigidimento.
Oggi, Leone XIV incarna un’idea di Chiesa in uscita, aperta, accogliente, ma lo fa senza la tentazione di cancellare ciò che lo precede: non disconosce, non dileggia, non recide la continuità di questi duemila anni. E qui i cronisti vanno in affanno: perché un Papa che unisce mitezza e autorevolezza, che denuncia le derive senza alzare la voce e senza teatralizzare la condanna, è più difficile da trasformare in “titolo”. Eppure, proprio questa gentilezza ferma è ciò che, oggi, rende il suo linguaggio più credibile e la sua presenza più facilmente accolta. Negli anni scorsi, una parte della stampa ha trovato terreno fin troppo fertile nel confezionare titoli punitivi contro il clero e l’istituzione: l’operazione riusciva con facilità, perché il Papa stesso adottava un registro percussivo, e ai cronisti bastava limitarsi a un meccanico “copia e incolla” del tono e delle parole.
Nel discorso natalizio del 2014, Francesco impostava l’intervento come una diagnosi pubblica: un elenco di “malattie” e tentazioni, un lessico volutamente urtante, pensato per scuotere e mettere a nudo dinamiche interne. Quel linguaggio, però, si è rivelato poco incisivo proprio su chi avrebbe dovuto lasciarsene interpellare fino alla conversione, mentre ha funzionato benissimo come materia prima per la narrazione mediatica. Con il passare degli anni, la reiterazione di un registro correttivo e punitivo - spesso privo della misura richiesta dalla delicatezza del ruolo - ha spostato l’effetto complessivo: invece di generare un miglioramento duraturo, ha consolidato un clima di ripiegamento, rabbia e difesa identitaria.
La psicologia della correzione continua: dalla coscienza alla difesa
La Chiesa si lascia trasformare quando la critica diventa materia di discernimento e di lavoro, non uno strumento brandito contro la dignità delle persone o contro l’istituzione nel suo insieme. Perché accada, chi ascolta deve poter riconoscere nel richiamo una via praticabile, senza sentirsi sottoposto a una svalutazione globale. Quando invece l’individuo avverte di essere inchiodato, la psiche cerca istintivamente una via di protezione: talvolta assume le sembianze dell’obbedienza, più spesso scivola in forme meno visibili di resistenza, irrigidimento, opposizione sommersa. Dentro questa dinamica si comprende un paradosso che molti, in Curia, hanno sperimentato negli ultimi anni: quando il rimprovero diventa consuetudine, la sua forza generativa si consuma. Aumentano il sarcasmo e la fatica, e può insinuarsi un’ostilità personale capace di corrodere i rapporti. Il nodo non sta nel valore della diagnosi, né nella sua fondatezza; sta nell’impatto della forma ripetuta, che finisce per rendere la verità psicologicamente “inabitabile”. Se manca una cornice percepita come affidabile - costruita su fiducia, riconoscimento e possibilità concreta di cambiamento - la correzione continua alimenta risentimento e riduce proprio quella responsabilità che vorrebbe suscitare.
In fondo, su molte questioni, ciò che diceva Papa Francesco e ciò che oggi dice Leone XIV non si discosta dalla linea sostanziale dei predecessori. La differenza passa dal modo in cui la parola viene consegnata. C’è una distanza enorme tra un’affermazione che inchioda l’interlocutore a un’etichetta e un richiamo che individua una tentazione da combattere. Nel primo caso la frase suona come una sentenza; nel secondo apre un margine di libertà, chiama alla vigilanza e rende possibile la conversione senza trasformarla in umiliazione.
Il clima come messaggio: perché il sorriso conta
Nel discorso pronunciato ieri, Leone XIV non rinuncia a segnalare derive e rischi. Lo fa, però, dentro un impianto che parte da una domanda concreta - l’amicizia, la fraternità, la lealtà nelle relazioni - e colloca la conversione dentro una cornice di missione e comunione. Il punto non è soltanto che “suona più positivo”. È che modifica l’assetto psicologico dell’ascolto. Un clima sereno e non aggressivo produce un effetto misurabile: abbassa le difese, aumenta la disponibilità a riconoscere un problema senza viverlo come un’umiliazione. In altre parole: rende possibile assumersi responsabilità senza cercare un nemico. E questo, nella vita quotidiana della Curia, significa molto. Perché l’istituzione cambia quando le persone smettono di muoversi per paura e ricominciano a muoversi per convinzione.
Non a caso, in questi primi mesi di pontificato, molti hanno percepito un ambiente più disteso. Non è un dettaglio psicologico da salotto clericale: è una variabile di governo. Il modo in cui un Papa entra in una sala, il modo in cui guarda e saluta, il modo in cui accoglie i suoi interlocutori, il modo in cui non alimenta tensioni, incide sulla qualità delle relazioni e sul lavoro ordinario.
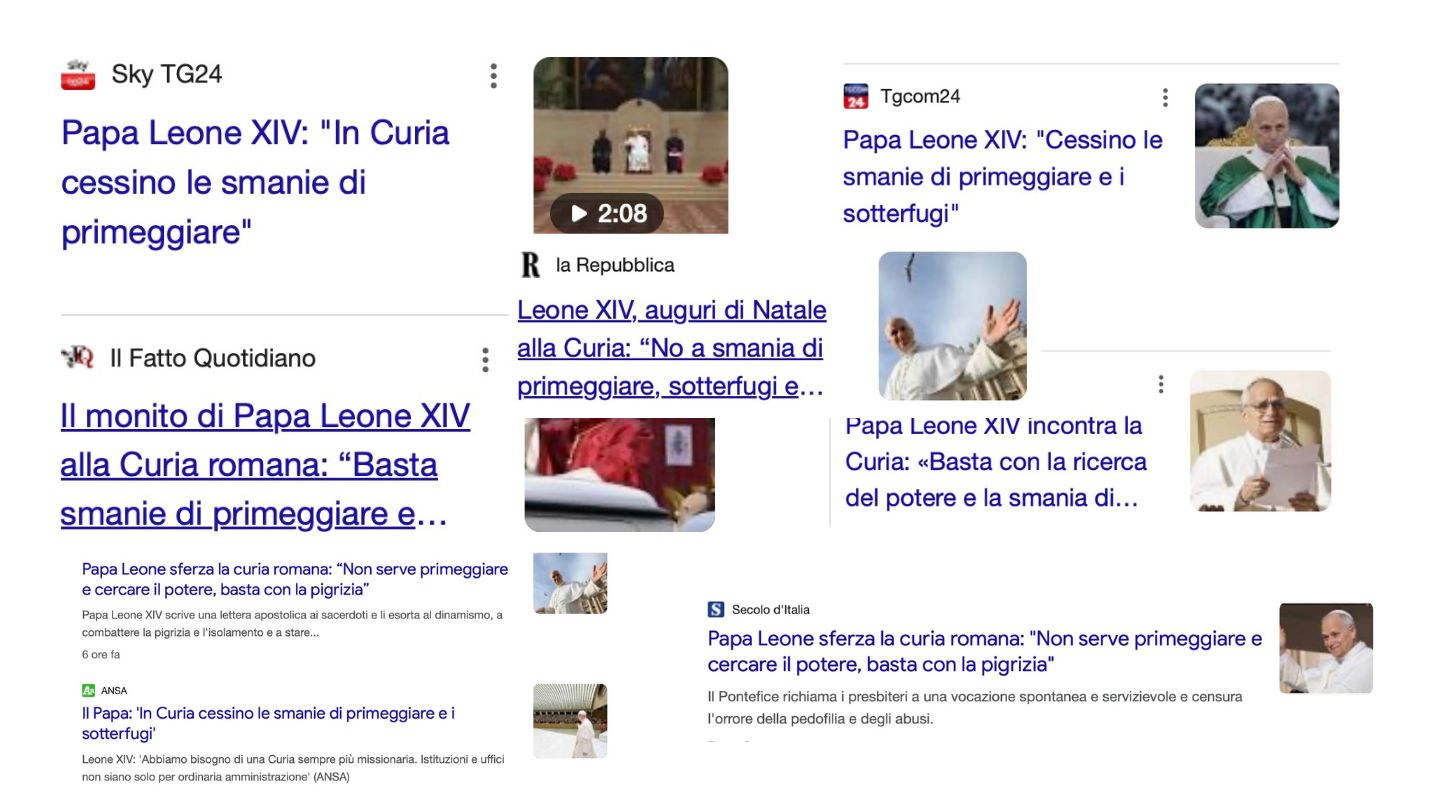
La distorsione esterna: titoli “francescani” per un Papa che parla diversamente
Devo soffermarmi, necessariamente, sulla narrazione mediatica italiana. In queste ore molti titoli hanno riprodotto, quasi senza scarto, schemi e toni ereditati dalla stagione precedente: polarizzazione, drammatizzazione, un lessico da contrapposizione. È un automatismo consolidato: per anni la scena è stata letta attraverso la coppia narrativa del Papa che “bacchetta” e della Curia che “incassa”. Oggi il Pontefice è cambiato, ma la griglia interpretativa è rimasta la stessa. Il punto critico è che questa griglia, a forza di ripetersi, assume un tratto manipolativo: invece di raccontare l’evento, lo costringe dentro un formato pensato per catturare attenzione e generare clic. Quando poi la materia prima - il tono effettivo del discorso - non concede appigli al “titolone”, interviene una sorta di riscrittura: si isolano e si ingigantiscono i passaggi di denuncia, si impoverisce il contesto, si attribuisce una durezza che in realtà apparteneva a un registro ben diverso.
In questo, Leone XIV si colloca con naturalezza in una tradizione comunicativa che molti riconoscono nei suoi predecessori - da Benedetto XVI a Giovanni Paolo II, da Giovanni XXIII fino a Pio X: frasi limpide nei contenuti, capaci anche di mettere in guardia dalle derive senza attenuarne la gravità, pronunciate però con una gentilezza istituzionale che non cerca slogan, non alza la voce e non ricorre al tono accusatorio per affermare la propria autorevolezza. È una differenza sostanziale, perché sposta la percezione: la denuncia non arriva come condanna, arriva come invito alla responsabilità.
Questo scarto disorienta una parte dell’ecosistema mediatico italiano, soprattutto quel giornalismo che non vive davvero certi luoghi e si accontenta di raccontarli “da fuori”, talvolta con un livore che affonda in vicende personali e storie irrisolte nei confronti del clero. Chi non abita la vita ecclesiale ma pretende di descriverne il respiro finisce spesso per proiettare categorie precostituite. E oggi quelle categorie restano ancora imbevute del registro conflittuale della stagione precedente, soprattutto nei momenti pubblici in cui l’esposizione dell’altro al pubblico ludibrio veniva trattata come una virtù comunicativa.

La questione dei risultati: efficacia pastorale e convenienza mediatica
C’è un punto, infine, che aiuta a capire perché questa distorsione continui a convenire: la mitezza “rende meno” nel mercato dell’attenzione. La comunicazione aggressiva attiva la polarizzazione; la polarizzazione produce clic; i clic alimentano ricavi e visibilità. Un linguaggio che affronta i problemi senza trasformarli in spettacolo è più difficile da impacchettare come “notizia”, soprattutto quando non offre il lessico dello scontro. È esattamente ciò che Leone XIV ha chiesto di correggere sin dall’inizio del pontificato, rivolgendosi ai media con una consegna netta: promuovere una comunicazione che non insegua il consenso “a tutti i costi”, che non si vesta di parole aggressive, che respinga il paradigma della competizione e dica no alla guerra delle parole e delle immagini; una comunicazione “disarmata e disarmante”, capace di ascolto, che separi i pregiudizi dalla ricerca della verità e non la dissoci dall’amore con cui va cercata. In quella prospettiva, l’invito a “disarmare” la comunicazione è una scelta culturale che incide sulla qualità della convivenza. Se, allora, la domanda è quale formula funzioni di più, la risposta passa dalla dinamica concreta degli effetti. Un linguaggio che espone e umilia può ottenere adesioni di facciata, silenzi e paure; un linguaggio che responsabilizzadentro un clima sereno favorisce più spesso un cambiamento reale, perché rende praticabile la conversione senza fabbricare nemici.
La differenza tra Francesco e Leone XIV, in definitiva, non sta nella direzione delle critiche o nella sostanza dei richiami. Sta nell’impatto umano che il linguaggio produce. Il primo ha spesso scelto la percussione come leva, con il rischio di irrigidire e accumulare rancori; il secondo mostra che la verità può essere detta senza adottare il registro della contrapposizione, e che persino questa “benedetta Curia” - proprio perché fatta di uomini e donne in cammino - cambia più facilmente quando si sente chiamata alla comunione, non inchiodata alla vergogna.
Marco Felipe Perfetti
Silere non possum