Camaldoli - Il Priore Generale della Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto, Dom Matteo Ferrari, ha inviato una lettera ai priori, vicepriori, responsabili delle residenze, maestri dei novizi e dei professi semplici.
Voglio anzitutto evidenziare un punto che considero gravemente inopportuno: la pubblicazione su Facebook di una lettera che riguarda proprio l’uso dei social nella vita monastica. L’abate la rende pubblica sul proprio profilo, attivo da anni, e lo fa con un mezzo che nel testo viene presentato come area su cui vigilare. Il corto circuito è evidente. Per un monaco, poi, la questione è ancora più delicata: qui non si parla di un religioso o di un prete secolare. La vocazione monastica si fonda su distacco, custodia della cella, silenzio, stabilità. In questo orizzonte, un profilo personale sui social rischia di contraddire l’impianto stesso della propria vocazione. L’uso dei social, se mai, riguarda altri ministeri e altre forme di vita ecclesiale.
Il Priore generale dell’Ordine camaldolese, inoltre, sa bene che certe comunicazioni interne, una volta rese pubbliche, vengono immediatamente strumentalizzate all’esterno. Non diventano occasione di confronto serio, ma materiale per colpire la vita monastica, per alimentare la narrativa secondo cui “nei monasteri non si vive bene la vita monastica”. È una dinamica prevedibile: questi temi attirano polarizzazione, non dibattito. Proprio per questo la lettera avrebbe dovuto restare riservata ai destinatari indicati, dentro un circuito di responsabilità e discernimento comunitario, senza trasformarsi in contenuto per una piazza digitale.
Detto questo, e per dare contesto senza restare impantanati nelle premesse, pesa anche la cornice complessiva da cui proviene il documento. Stiamo parlando di un priore che, a Camaldoli, da anni ospita un sedicente liturgista apertamente favorevole all’ordinazione delle donne; che ha consentito ai monaci di intraprendere percorsi come corsi di yoga e incontri dedicati al buddismo; e che, nel negozio del monastero, ha lasciato circolare e mettere in vendita testi su yoga e buddismo. Sono scelte che indicano un orientamento preciso e, proprio per questo, rendono meno credibile la pretesa di ergersi a custodi di sobrietà e disciplina nel già fragile discorso su media e monachesimo. Detto ciò, si può anche leggere la lettera come una sorta di ammissione e di cambio di passo, come se Ferrari stesse dicendo: “Fin qui abbiamo consentito troppo; ora è tempo di conversione e di regole chiare”.
A questo si aggiunge un episodio simbolico e, per molti versi, stonato: l’ingresso del Priore generale nel circuito del Sinodo sulla Sinodalità in veste di “cerimoniere”. Un monaco che si sposta in quel contesto, già di per sé lontano dalla grammatica monastica della vita ritirata, è qualcosa che suscita interrogativi. Ma qui non si tratta di un monaco qualunque: è il superiore generale, quindi una figura che rappresenta un’intera Congregazione. E la funzione affidata, per di più, lo colloca in una dinamica di visibilità e gestione liturgico protocollare che mal si accorda con l’idea di discrezione monastica.
Come venne “arruolato” Ferrari? Con il solito sistema vaticano. Il cardinale Mario Grech andò a Camaldoli, rimase colpito dalla liturgia che vide e gli chiese di andare al Sinodo. Anche questo ci dice molto del cardinale maltese: a Camaldoli la liturgia, da tempo, è ben poco aderente a un impianto propriamente benedettino e monastico, e che proprio quella cifra sia stata “gradita” dice molto del clima ecclesiale in cui stiamo vivendo.
In sostanza, il contenuto della lettera può anche toccare problemi reali, ma la scelta di pubblicarla su Facebook, da parte di chi invita a vigilare sui social, indebolisce la credibilità del messaggio e apre la strada a strumentalizzazioni. E quando questo avviene dentro un quadro di scelte già controverse sul piano identitario, la lettera rischia di diventare l’ennesimo elemento di confusione, più che un aiuto serio alla riforma della vita monastica.
Il contenuto della lettera, però, non è da archiviare con leggerezza. Al contrario, offre un’occasione concreta per ragionare su una questione che, in misura diversa, attraversa oggi quasi tutti i monasteri. Dom Matteo mette a tema l’uso di internet, smartphone, social, video e film online, e di WhatsApp “senza regole”, qualificandoli senza ambiguità come “una sfida per la vita monastica e religiosa” e aggiungendo: “Non possiamo far finta che questa sfida non esista”.
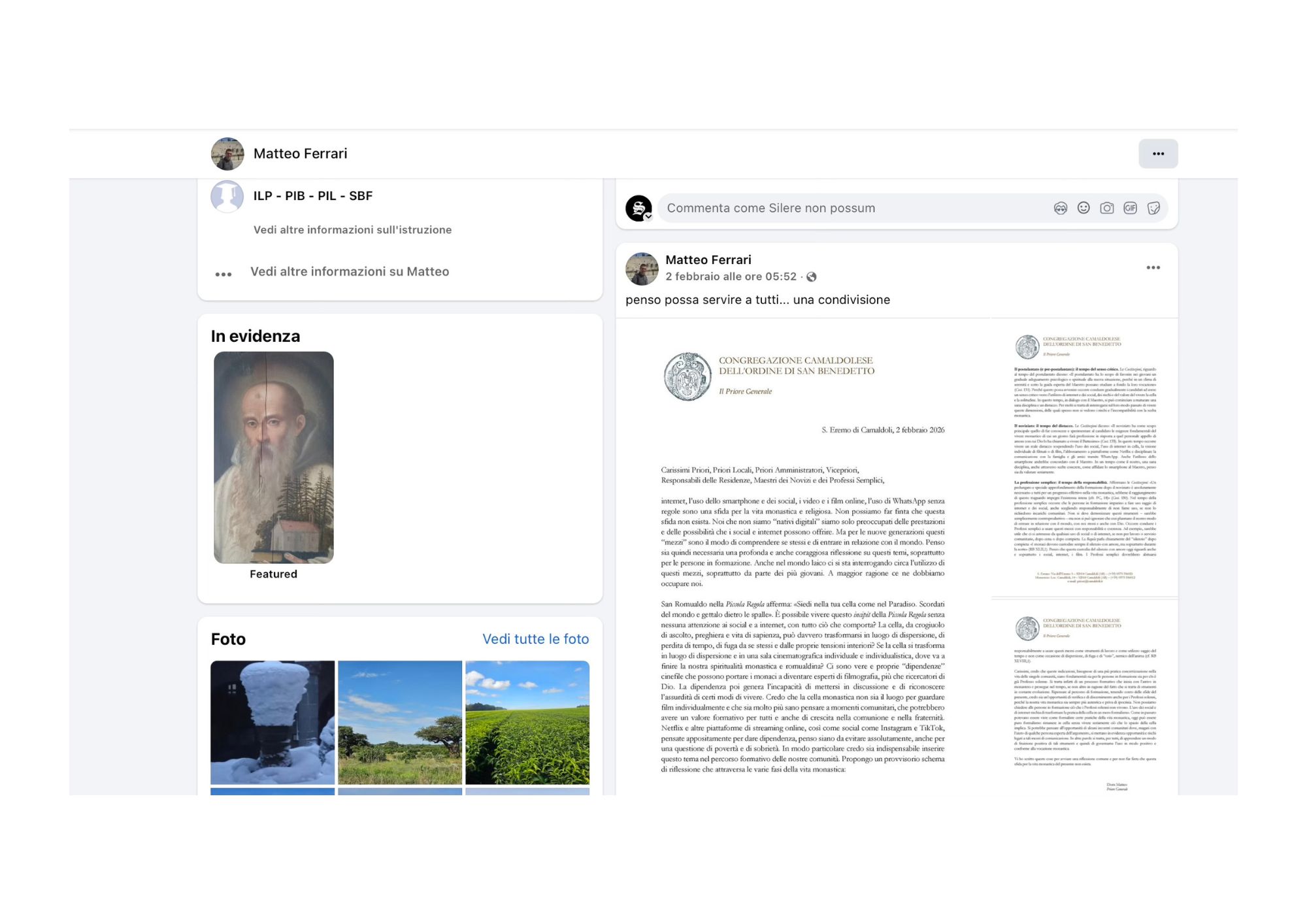
Perché la diagnosi regge, oggi, più di ieri
La lettera intercetta un dato che molte comunità conoscono già dall’interno: il rischio di una vita parallela che cresce senza dichiararsi. In diverse abbazie e monasteri la giornata può restare formalmente intatta, coro, refettorio, lavoro, capitolo, e insieme svuotarsi nella sostanza, quando il tempo “libero” viene inghiottito da schermi e notifiche. La conseguenza non è soltanto un problema di disciplina; è una lenta erosione di presenza, responsabilità e comunione, cioè degli elementi che rendono riconoscibile la vita monastica.
Ci sono poi alcune abbazie, in particolare nei Paesi germanofoni, dove l’affidamento stabile della cura pastorale di parrocchie esterne finisce per aprire, di fatto, maggiori margini di fuga. Accade che, terminata l’attività parrocchiale, non si rientri in monastero: non per una reale necessità, ma perché la vita comunitaria è percepita come pesante o malfunzionante e, allora, si preferisce restare fuori. Il problema viene facilitato da una configurazione ancora presente in alcuni ordini, che consente una gestione molto ampia degli spazi e dei tempi extra claustra, fino a rendere strutturale ciò che dovrebbe restare eccezione.
La cella tra ascolto e dispersione
Dom Ferrari aggancia il tema alla tradizione romualdina. Cita San Romualdo nella Piccola Regola: “Siedi nella tua cella come nel Paradiso. Scordati del mondo e gettalo dietro le spalle”. La parola scordati richiama un atto della volontà: togliere dal cuore ciò che reclama possesso, mentre “dimenticare” può restare anche involontario. Su questa soglia il Priore generale pone la domanda decisiva: la cella, “da crogiolo di ascolto, preghiera e vita di sapienza”, può “trasformarsi in luogo di dispersione, di perdita di tempo, di fuga da sé stessi e dalle proprie tensioni interiori?”. E avverte del passaggio concreto: “una sala cinematografica individuale e individualistica”, con “vere e proprie dipendenze cinefile”.
Piattaforme pensate per agganciare
Il Priore non edulcora. Parla di “Netflix e altre piattaforme di streaming online” e di social come “Instagram e TikTok”, descrivendoli come realtà “pensate appositamente per dare dipendenza” e che “penso siano da evitare assolutamente”, anche “per una questione di povertà e di sobrietà”. Qui la lettera tocca un nervo spirituale prima ancora che morale: ciò che addestra alla gratificazione immediata indebolisce la capacità di restare nella stabilità, di reggere l’aridità, di attraversare il limite senza cercare subito un anestetico.
Postulantato: educare il senso critico
Il Priore generale indica una linea di lavoro che inserisca questa preoccupazione dentro il percorso formativo già previsto, con tappe distinte, a partire dal postulantato inteso come “tempo del senso critico”. Richiama le Costituzioni: il postulantato serve a favorire “un graduale adeguamento psicologico e spirituale alla nuova situazione” perché i giovani, “in un clima di serenità e sotto la guida esperta del Maestro”, possano “studiare a fondo la loro vocazione” (Cost. 131). L’uso di internet e dei social viene affrontato, giustamente, come materia di discernimento: rischi, valore della cella e della solitudine, disciplina che si impara “in dialogo con il Maestro”.
Noviziato: il distacco come prova concreta
Nel noviziato la lettera chiede un passo ulteriore: “vivere un reale distacco”, sospendendo “l’uso dei social”, “l’uso di internet in cella”, “la visione individuale di filmati o di film”, e “l’abbonamento a piattaforme come Netflix”. Anche la comunicazione con famiglia e amici, “tramite WhatsApp”, va “disciplinata”. Lo smartphone viene posto sotto un criterio esplicito: “andrebbe concordato con il Maestro” e persino l’ipotesi di “affidare lo smartphone al Maestro” viene indicata come scelta concreta da valutare seriamente. Del resto, il monaco non è il prete secolare e non è neppure un religioso qualunque. Il monaco è chiamato ad una vita del tutto particolare e spesso qualcuno non comprende la peculiarità di questa vita proprio perché non vi sono differenze reali con quella del prete o del religioso.

Professione semplice: responsabilità e custodia della notte
Per la professione semplice, Dom Ferrari parla di “tempo della responsabilità”: imparare “a fare uso saggio” di internet e social, anche scegliendo responsabilmente di non usarli se non richiesti da incarichi comunitari.E formula una regola pratica: astenersi da qualunque uso “dopo cena o dopo compieta”. Nella Regola di san Benedetto, il grande padre del monachesimo parla del silenzio: “I monaci devono custodire sempre il silenzio con amore, ma soprattutto durante la notte” (RB XLII,1). Il punto non è l’ascetica del divieto; è la protezione di un territorio interiore, quello in cui si gioca la fedeltà al giorno seguente.
Professi solenni: la coerenza come condizione di credibilità
Nella parte conclusiva la lettera concentra l’attenzione su chi è già Professo solenne. Il Priore generale ricorda che il cammino formativo “prosegue nel tempo” e mette nero su bianco un criterio che non può essere aggirato: “Non possiamo chiedere alle persone in formazione ciò che i Professi solenni non vivono”.
È un passaggio decisivo perché chiama in causa la credibilità del monastero. Dove la vita è vissuta con serietà, senza doppiezze, spesso nascono anche vocazioni e, non di rado, vocazioni giovani. La fragilità personale non è lo scandalo: il monaco resta uomo, cade, si rialza, si santifica dentro una conversione quotidiana. Lo scandalo, semmai, è la resa culturale mascherata da tolleranza, la logica del “liberi tutti” elevata a norma implicita. Un’altra cosa è tenere ferma una direzione comune: indicare una meta, riconoscere le fatiche, camminare insieme sostenendosi e correggendosi. In questa linea si comprende bene anche l’equilibrio della Regola di san Benedetto, quando chiede all’Abate di unire fermezza e carità: “deve correggere energicamente gli indisciplinati e gli irrequieti” e, insieme, “esortare amorevolmente quelli che obbediscono con docilità a progredire sempre più”. Nelle parole del santo padre non c’è alcun permissivismo, ma una pedagogia realistica: la comunità cresce se chi guida non abdica e se chi è formato vede nei formatori una vita coerente, non un sistema di eccezioni.
Ferrari parla molto chiaro: “L’uso dei social e di internet rischia di trasformare la pratica della cella in un mero formalismo”. È un passaggio che fotografa una patologia ormai diffusa: si conservano alcuni segni esteriori della disciplina, mentre la sostanza viene lentamente spostata altrove, in spazi privati non condivisi. La vita comune rischia così di ridursi a una sequenza di gesti ripetuti per inerzia e per obbligo, una coreografia tenuta in piedi dall’abitudine più che da una convinzione interiore. «Vado in coro perché sennò mi richiamano», a volte siamo tentati di pensare. Ma in realtà in coro dovrei andare ben contento di andare a pregare Dio con la mia comunità. In alcune realtà, infatti, credo si sia andati addirittura oltre. Non si avverte più nemmeno l’urgenza di salvare l’apparenza, perché è venuto meno il pudore di presentare come “normale” ciò che con la vita monastica ha poco a che vedere. E Camaldoli, a mio avviso, rientra tra questi casi: non solo la sostanza si indebolisce, ma si smette di percepire come problema il fatto stesso di indebolirla.
L’accidia di Cassiano e lo schermo come varco di fuga
La tradizione ci aiuta a leggere il presente senza moralismi sterili. Giovanni Cassiano chiamava accidia quella febbre dell’anima che rende intollerabile il luogo in cui si vive, irrigidisce lo sguardo sui fratelli, svuota la preghiera e la lettura. Oggi la fuga può consumarsi senza attraversare il chiostro: basta aprire uno schermo. Il corpo resta in cella, l’attenzione scivola altrove, e il monastero rischia di diventare un insieme di solitudini connesse, dove la comunità si incontra ma non si abita. Si mal sopporta il confratello, si evita l’abate e ai momenti comunitari si va controvoglia.

San Benedetto: primato dell’Opus Dei e disciplina comune
La Regola di san Benedetto, che resta sorprendentemente attuale e non perde forza con il tempo, non parla di algoritmi, ma conosce bene l’uomo. Il criterio operativo rimane la priorità dell’Opus Dei e della disciplina comune: quando suona la campana, si interrompe ciò che si sta facendo. Trasposto nell’oggi, questo significa che nessun dispositivo può ottenere uno statuto privato tale da ridimensionare coro, refettorio, lavoro e capitolo.
E quando Benedetto definisce l’“ozio” “nemico dell’anima”, non sta facendo una considerazione aleatoria o vetusta: descrive un meccanismo spirituale concreto che, oggi, può essere alimentato da ore di scorrimento su TikTok o dal consumo solitario di film su Netflix, proprio perché si presentano come innocui, come semplice “riposo”, mentre in realtà frammentano la presenza e indeboliscono l’unità della giornata monastica.
Una proposta implicita: regole verificabili e vita comunitaria
Dom Ferrari suggerisce “incontri comunitari” con l’aiuto di persone esperte, per mettere a fuoco opportunità e rischi e “governare l’uso” in modo positivo e conforme alla vocazione monastica. È una direzione concreta: fissare luoghi, orari, finalità, e introdurre una verifica reale. Anche la fruizione di contenuti, quando necessaria, può assumere una forma comunitaria, perché riduce l’isolamento e obbliga a un criterio condiviso. Senza questo perimetro, la tecnologia rischia di diventare una zona sottratta al discernimento e capace di ridisegnare la giornata attorno a un’agenda privata.
In fondo, la lettera di Ferrari dà un nome a ciò che spesso si ha paura di nominare, e che invece attraversa molte comunità, monastiche e non: la dipendenza. Proprio la solitudine della cella può diventare un terreno favorevole, perché permette di coltivare abitudini e compensazioni lontano dallo sguardo fraterno e dal confronto, con la tentazione di evitare il giudizio e, più ancora, di evitare la verità su di sé.
Le dipendenze possono essere da sostanze, e presentarsi in forme più o meno visibili: alcol, nicotina, cannabis e altre droghe, ma anche l’uso distorto di farmaci assunti come scorciatoia emotiva, sedativi, ansiolitici, analgesici, fino a renderli un rifugio abituale.
Possono essere comportamentali, e qui il mondo digitale offre un repertorio quasi infinito: social network, scroll compulsivo, video brevi, streaming e binge watching, consumo solitario di contenuti, gaming, chat e messaggistica continua, shopping online, ricerca incessante di stimoli e novità. Ci sono poi dipendenze che non passano necessariamente dallo schermo ma funzionano allo stesso modo: pornografia, gioco d’azzardo, rapporto disordinato con il cibo, e perfino forme di attivismo o di lavoro che, più che servizio, diventano anestesia e fuga dalla vita comune. In alcuni casi la dipendenza assume un volto “rispettabile” e per questo più difficile da smascherare: consumo compulsivo di notizie, bisogno di controllo, perfezionismo, oppure una certa forma di spiritualità usata come riparo emotivo invece che come conversione reale.
Ecco perché la proposta di Ferrari non va lasciata cadere. Tocca la vita psicologica e spirituale del monaco e, nel governo e nella formazione, dare un nome alle cose resta decisivo. Sarebbe stato preferibile evitare di esporre tutto sulla vetrina di Facebook, ma il punto sostanziale rimane: ciò che resta nascosto tende a ingrandirsi e a radicarsi; ciò che viene nominato, messo sotto discernimento e accompagnato può essere curato, corretto e ricondotto al servizio della vita monastica. Anche per questo nominare i problemi è utile: il monaco che si riconosce in una fragilità, sentendola finalmente detta, può smettere di viverla come una vergogna isolata e arrivare a pensare: “Non sono l’unico a combattere questa difficoltà, dunque esiste anche un cammino di guarigione”.

La posta in gioco: non fingere, non delegare, non banalizzare
La missiva si chiude con una frase che è una consegna: “Vi ho scritto queste cose per avviare una riflessione comune e per non far finta che questa sfida per la vita monastica del presente non esista”. Queste parole, quindi, obbligano ad una scelta: o la Congregazione prende in mano la questione con discernimento, oppure la lascia scorrere e la subisce. In quel caso la vita monastica può continuare a reggersi per inerzia, ma per poco: basta guardare ai numeri, alle comunità sempre più anziane, ai novizi sempre più rari, tra i Camaldolesi e ben oltre l’ambito camaldolese. Negli ultimi anni lo si è visto con chiarezza: molte crisi non sono esplose con scandali o episodi eclatanti. Sono entrate in silenzio. La vita comunitaria si è progressivamente raffreddata, la vita liturgica si è assottigliata fino quasi a scomparire, la cella ha smesso di essere un luogo di preghiera e di ascolto ed è diventata un rifugio, e la stabilità si è ridotta a una semplice permanenza fisica, senza quella conversione del cuore che sola dà senso alla clausura e alla perseveranza.
Per questo le parole di Ferrari meritano di essere prese sul serio e tradotte in scelte concrete. Se restano lettera morta, la sfida continuerà a lavorare in sotterraneo; se invece diventano occasione di discernimento e di riforma, possono aprire un vero rinnovo della Congregazione Camaldolese. Il suo carisma ha una forza reale, una spiritualità capace di parlare al cuore dell’uomo, e oggi avrebbe ancora più ragioni per essere proposta nella sua essenza, senza aggiunte ideologiche e senza scorciatoie. C’è una generazione che non cerca intrattenimento religioso, ma Dio; che non chiede esperimenti, ma una vita credibile; che avverte la stanchezza di un mondo che vuole anestetizzare e omologare, spesso anche attraverso i social, dove la polarizzazione divora l’incontro. Proprio per questo il monachesimo è una risposta. Non perché si sottrae alla realtà, ma perché custodisce l’unica cosa che la realtà non riesce a darsi da sola: un luogo dove ascoltare, nel silenzio, Dio.
Beata solitudo, sola beatitudo
p.V.B.
Silere non possum